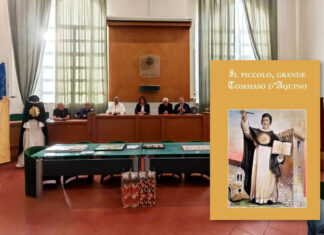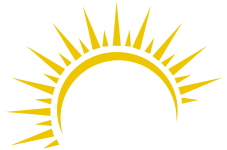Il lessico teoretico presentato a
Madonna dell’Arco il 23 settembre 2025
Padre Vladimiro Caroli O.P.
1. Presentazione del progetto
Questo Lessico teoretico della “Somma di teologia” nasce per mettere il lettore a contatto diretto con il significato che le parole hanno nella mente dell’Aquinate stesso.
Infatti, ogni concetto, impresso nella mente di un autore, è come un punto di partenza, una cosa prima: princìpi da cui inizia a ragionare. Perciò, l’idea non fu un repertorio di sinonimi, ma uno strumento d’accesso a tali princìpi del pensare. E le voci, vergate dall’autore nel testo, sono i simboli di tali cose prime nella mente di lui: non nella nostra.
2. Come nacque l’idea
«L’idea», scrive il Fiorentino, fu di «Giovanni Reale (†2014)»: un Lessico come corredo alla traduzione della Summa, affidata da lui al Fiorentino e pubblicata, poi, da Città Nuova nel 2019.
Il Reale aveva apprezzato la tenuta del metodo delle parole‑chiave nel Trattato sui segni di Giovanni di San Tommaso, dove Fiorentino adottò un principio radicale: il testo va interpretato mediante il testo e l’autore mediante l’autore. Canone centrale nel Lessico.
Ed era maturato rileggendo continuamente il De interpretatione aristotelico – dove la vox è «insieme simbolo e segno» dei παθήματα, cioè dei concetti – e traducendo il Trattato sui segni. Egli constatava così che la corretta interpretazione si gioca soprattutto sulla prima operazione dell’intelletto, quella dei concetti, cui le parole rimandano.
Perciò il metodo è una ermeneutica oggettiva, fondata sulla «autonomia dell’oggetto […] autonomia logico-ontologica del testo»: autonomia dei concetti che Tommaso aveva nell’intelletto, scrivendo quelle parole.
3. Il senso dell’opera
Il Lessico, infatti, risponde a un bisogno: leggere senza significati estranei al mondo interiore, formatosi in Tommaso «sin dalla nascita». È capitato – e in ottimi studi – di vedere termini di lui interpretati secondo «un senso diverso da quello […] nella sua mente quando scriveva».
Ciò accade quando si legge un testo «per cercare di comprenderlo». Invece, col Lessico teoretico prima si ricostruisce, voce per voce, il senso di quei nomi nella mente dell’autore; poi si leggono i testi. Dopo il primo canone centrale, questo è il secondo principio.
4. Criteri di lavoro
Il lavoro è stato guidato dai Fondamenti ermeneutici, volume introduttivo, e da criteri concreti:
- Centralità della res: quando una stessa realtà è espressa con più dizioni (ad es. «angelo», «sostanza intellettuale», «sostanza spirituale»), le voci sono state ricondotte all’unità concettuale (per es., sotto Angelo).
- Uso primario della Summa: è il testo di base; solo in pochi casi, per completare nozioni altrimenti monche (ad es., Essere), si è ricorsi ad altri scritti tommasiani.
- Relazioni tra le voci: le voci sono una rete pensata (rinvii, nessi); per parole con più accezioni (ad es., Potenza), la rete fa emergere la sfumatura voluta da Tommaso.
- Adattamento formale: le citazioni adattate al nuovo registro sintattico, ma senza alterarne il contenuto formale.
5. Supervisione editoriale e serietà scientifica
Le voci dei collaboratori sono state supervisionate dal Fiorentino, con modifiche e integrazioni, se necessario. Quindi coerenza teoretica dell’opera e… col metodo: non è un mosaico, ma un lessico unitario; c’è una mano che… presidia ogni cosa.
6. Il gruppo di lavoro
Hanno contribuito dottori di ricerca o docenti anche universitari: Caroli, Casciano, Ciriolo, De Iaco, Masciullo, Mastrobisi, Nutricati, Piemonte, Spezia, Vendemmiati.
Le voci da loro firmate sono (numericamente) definite; il curatore, invece, ne ha compilate molte centinaia.
7. Perché «teoretico»?
Teoretico – Non soltanto storia delle parole, ma ricostruzione dei concetti/princìpi, cose prime che le parole esprimono e di cui sono simbolo. Perciò, Fiorentino non dice di aver computato ma «compulsato» i luoghi pertinenti della Summa. Il risultato è uno strumento che non appiattisce in una lista di occorrenze, ma orienta la lettura: definisce i significati, mostra le differenze, evita cortocircuiti concettuali (proiezioni del lettore, riscritture che coprono i concetti dell’autore).
8. Il metodo in tre mosse
- Prima operazione dell’intelletto;
- L’autore con l’autore: compilare le definizioni con le sue stesse parole;
- Lettura orientata per il lettore.
9. Che cosa offre al lettore
Tre vantaggi:
- Precisione semantica: mette in sicurezza i significati.
- Coerenza sistematica: evidenzia i nessi tra le voci.
- Affidabilità: l’unità redazionale.
10. Una parola sui ringraziamenti
Dietro le quinte c’erano maestri e sostenitori. Accanto ai collaboratori, un pensiero va al compianto maestro Giovanni Reale e alla provincia domenicana di San Tommaso d’Aquino in Italia, al provinciale uscente, p. Ricci, che ha reso possibile la concreta pubblicazione e al nuovo Provinciale, p. Catalano, che ha voluto essere qui rappresentato.
11. Conclusione
Il Lessico propone una disciplina semplice ma severa: tornare al significato delle parole a partire dall’autore. È una bussola per leggere la Somma di teologia con rigore, senza sovrapporvi i nostri concetti.
Chi studia Tommaso troverà, qui, non un compendio di opinioni, ma un invito metodico: «prima il lessico, poi la lettura». È il modo più leale e fecondo di entrare nella bottega di uno dei massimi maestri.
Gallery